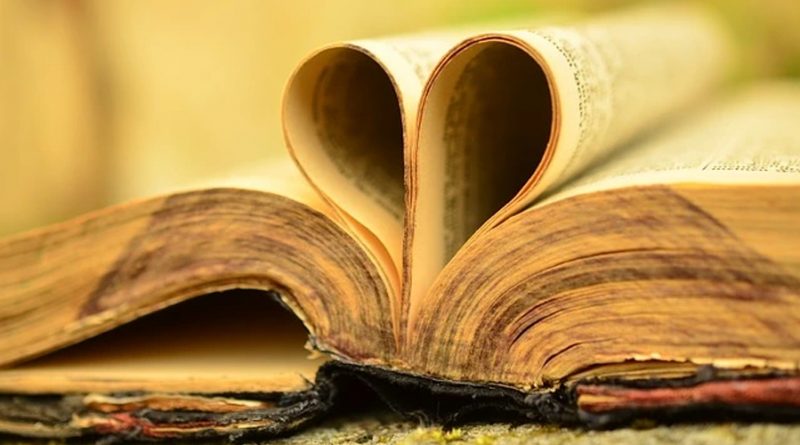L’amore nel Cap 13 della prima lettera ai Corinzi
Germogli
“germogli” è una collanina, nata quasi per caso, dopo una riunione nella quale mi era stato chiesto di proporre una breve meditazione;
“germogli” è una cosa piccolissima, debole, un timido inizio, niente di ambizioso;
“germogli” ha la pretesa di mettere in comune qualche passo nel cammino di fede guardando alla Scrittura e sapendo che «né chi pianta è qualcosa, né lo è chi irriga, ma è Dio che fa crescere» (1Cor 3,7).
Alberto Bigarelli
di Alberto bigarelli

Stesura dell’incontro formativo Caritas (1 luglio 2011)
- Il comandamento dell’amore, nei due aspetti dell’amore verso Dio e verso il prossimo, appare più di una volta nel Nuovo Testamento. Ricorderete il brano di Marco in cui lo scriba chiede a Gesù: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». E la risposta: «Il primo è … amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è altro comandamento più grande di questi» (12,28-34; vedi i paralleli Mt 22,34-40; Lc 10,25-28). Gesù, rispondendo, dice che i comandamenti sono in realtà due e lega insieme l’amore per Dio – come amore prioritario – e quello per il prossimo, che discende dal primo e se ne alimenta.
- In altri luoghi, si insiste sull’amore fraterno. Ad es. in Romani: «Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge … La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità» (13,8.10). Ritorna anche qui il richiamo alla legge mosaica il cui senso si concentra nell’amore fraterno.
Vediamo la 1Pt: «Dopo aver purificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri» (1,22).
La 1Gv sarebbe da riportare quasi per intero; mi limito a tre brevi citazioni:
«Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi (2,9-11);
«Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte» (3,14); «Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore … Se uno dice: “Io amo Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello» (4,8.20s.).
I brani della 1Gv contengono affermazioni forti che si possono riassumere così: non amare i fratelli equivale ad essere nelle tenebre ed essere ciechi; chi non ama i fratelli rimane nella morte, non ha in realtà conosciuto Dio nel quale dice di credere, chi non ama i fratelli non può affermare di amare Dio, è un bugiardo.
- Non si può proseguire il discorso se non si ricordano almeno due insegnamenti che portano l’amore a una radicalità più grande. Matteo, richiamando le parole di Gesù messe a confronto con i comandamenti della legge mosaica, scrive: «Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (5,43-48). Il prossimo può essere il tuo nemico, ma il discepolo di Gesù nel rapporto con quel fratello deve imitare Dio stesso che non manca di beneficare anche chi è lontano da lui, o meglio, chi è contro di lui. Il cristiano che si comporta così è veramente figlio di Dio (cf. Lc 6,27-36).
Il secondo insegnamento lo si trova in Giovanni: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”» (13,34s.). L’amore reciproco deve incarnare il comandamento “nuovo”: ma la novità è Gesù stesso, il suo amore fino alla fine: i tratti della sua umiliazione, dalla nascita alla croce, alla sepoltura. Il comandamento nuovo è vivere il suo amore.
- In tutti questi brani abbiamo incontrato affermazioni molto forti, nette, piene di bellezza sull’amore, ma l’amore non viene descritto se non indirettamente. Chi lo fa, con un intento celebrativo e descrittivo insieme, è l’apostolo Paolo in quello splendido inno contenuto nella sua prima lettera ai Corinti e che adesso prendiamo in considerazione.
Riporto per comodità il testo a partire dagli ultimi versetti del cap. 12:
«27 Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 28 Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. 29 Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? 30 Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? 31 Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime.
- 1 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. 2 E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.3 E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.4 La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio,5 non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,6 non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.7 Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.8 La carità non avrà mai fine Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. 9 Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 10 Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 11 Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. 12 Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. 13 Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!»
5. Il capitolo 13, che si colloca nel cuore della trattazione sui carismi (capp. 12-14) e che contiene l’Inno alla carità, non è in nessun modo una disgressione rispetto all’argomento trattato, ma piuttosto, come scrive P. Rossano, «ne segna il vertice spirituale».
Ma prima di fare una lettura più dettagliata che ci conduca a gustare la bellezza e la profondità spirituale dell’Inno, è necessario premettere qualche brevissima considerazione in vista di una intelligenza più adeguata del termine “carità”. Questa parola, che si trova nella versione ufficiale voluta dalla CEI per l’uso liturgico della chiesa italiana, non ha nulla a che fare con l’elemosina o con l’idea di solidarietà in senso largo. “Carità” è semplicemente la trascrizione del termine latino caritas, che comunque non rende adeguatamente ragione del termine originario greco agape. Del resto non sarebbe del tutto chiarificante neppure tradurlo con amore, anche se è più vicino, perché amore nella nostra lingua ha un arcobaleno di significati e bisogna isolarne qualcuno. La lingua latina invece ha un termine più conforme al senso del greco agape, ed è dilectio. A differenza della nostra, la lingua greca conosce vari vocaboli per rendere le sfumature dell’amore. I più importanti sono: philìa, storghé, èros e agàpe. Con philia si designa l’affezione, o l’inclinazione dell’uomo verso qualcosa o qualcuno e in particolare, nell’ambito dei rapporti umani, l’attaccamento, la simpatia, l’amicizia, la corrispondenza d’affetto fra eguali. Il sostantivo e il verbo corrispondente sono i più usati. Nel NT appare più frequentemente il verbo (phileo), anche in forme composte, ma eccetto singoli casi, il suo significato non è di particolare rilievo. Con storghé si esprime l’amore, la tenerezza fra fidanzati, fra gli sposi, l’affetto fra persone della stessa famiglia. Compare solo una volta nel NT in un termine composto philostorgos (cf. Rm 12,10); Il verbo è completamente assente nel NT. Eros è l’amore passionale, sensuale, possessivo fino alla violenza. Il sostantivo e forma verbale sono completamente assenti nel NT. Agape, invece, conosciuto nel greco classico, e senza particolari sfumature, come sinonimo di philia e storghé, viene assunto nel NT come capace di esprimere l’amore cristiano contenendo l’idea di benevolenza, di bontà, di stima, di apertura e disponibilità. Nell’Inno alla Carità si trova questo sostantivo ulteriormente illuminato dalla riflessione paolina.
Questa prima scrematura ha già liberato il campo da molti fraintendimenti che si attivano immediatamente, e forse inevitabilmente, ad una prima lettura del brano. Nell’Inno non si parla di un sentimento, non si parla dell’affetto fra amici o dell’amore fra due sposi, non c’é nulla che abbia a che vedere con l’emotività e l’irrazionalità che le è propria. Se si parlasse di questi sentimenti caratteristici del cuore umano, dovremmo concludere amaramente che l’amore-agape, il più grande di tutti i carismi verso il quale è doveroso essere ambiziosi, non è alla nostra portata. Sì, perché “al cuor non si comanda”. Come si può provare affetto, tenerezza, simpatia, per chi offende, insulta, imbroglia, commette ingiustizie, violenze, uccide, ecc. L’amore-agape invece si muove senza impacci in mezzo alle espressioni più varie del male, facendosene carico, operando con creatività e con fortezza nelle situazioni più contrarie.
- L’Inno è costruito con grande cura e vi si possono distinguere tre strofe:
- tutti i doni sono insufficienti se non sono sostanziati dall’amore-agape (vv. 1-3);
- le espressioni dell’amore-agape (vv. 4-7);
III. l’eternità dell’amore-agape rispetto ad ogni altro carisma; solo l’amore porta a pienezza l’esperienza cristiana (vv. 8-13).
- Dopo aver parlato della chiesa in parallelo col corpo umano, ed aver mostrato la solidarietà e la stima reciproca fra i membri della comunità, mettendo in parallelo karisma e agape, Paolo mostra che questo è l’unico dono divino indispensabile, sempre presente e attivo nella condotta cristiana, persino immutabile perché oltrepasserà le soglie della morte, si conserverà e si espanderà dopo di essa.
L’apostolo non disprezza i carismi, anzi ne loda la vitalità e li ritiene indispensabili all’edificazione della comunità. Egli esorta infatti i corinzi con le parole: «Aspirate ai carismi più grandi!» (12,31). In questo modo li incoraggia ad essere solleciti verso di essi mettendo l’accento sull’espressione “più grandi” che in questo caso vuol dire più utili all’edificazione comune (cf. 12,7; 14,12.26). In questo modo Paolo si prepara a portare la riflessione sul dono più efficace e più completo in rapporto ad uno stile di servizio più perfettamente conforme ad un’autentica interiorizzazione dell’evangelo. Egli infatti dice: «E io vi mostrerò una via migliore di tutte». Il termine “via”, senza entrare nella teologia del Deuteronomio o dei libri sapienziali, è d’uso comune nel NT per indicare sia una dottrina religiosa e morale, sia la condotta di vita ad essa conforme (cf. Mt 7,13-14; 22,16; 1Cor 4,17; At 2,28; 9,2; 18,25.26; 19,9.23; ecc.). Questa via, riservata ai discepoli del Cristo, e che è la via della verità e della giustizia, della vita e della salvezza, è quanto Paolo vuole insegnare: egli infatti dice «vi mostrerò». Riferendosi ad essa aggiunge che è la «migliore di tutte».
L’espressione greca “kath’yperbolén”(= la più sublime: CEI)non è un comparativo, come se l’amore-agape rappresentasse un grado superiore di perfezione rispetto ai carismi, ma è un superlativo al punto che non c’é confronto fra le manifestazioni carismatiche delle assemblee liturgiche di Corinto e questa via dell’amore-agape che è la perfezione stessa della fede cristiana. Ad essa tutte le altre espressioni dell’impegno religioso e morale cedono il passo e devono subordinarsi (cf. 8,1). Paradossalmente si potrebbe dire che se si può essere cristiani senza possedere nessun carisma, non è possibile ritenersi ed essere discepoli di Gesù senza possedere quello dell’amore-agape. I doni carismatici della glossolalia (v.1), della profezia, della scienza e della fede (v.2), il dono senza riserve di sé (v.3) non sono i valori più propriamente e squisitamente cristiani.
L’Apostolo ama l’iperbole ed usa questo mezzo letterario con grande efficacia.
«Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli» leggiamo in 1Cor 13,1. Il «parlare in lingue», così apprezzato a Corinto, è immaginato nella sua forma più alta: tutte le lingue possibili, anche le più perfette, le più elevate, le più sublimi, parlare divinamente (cf. 14,2). «Parlare in lingue», così da avere contatto e accesso a tutto il mondo terrestre e a tutto il mondo celeste è possibile solo per dono di Dio. Eppure se il suo beneficiario non possiede l’amore-agape non serve a nulla, è una cosa morta, un suono che passa, «un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna». Senza amore-agape la glossolalia non è una forma carismatica che edifichi (cf. 14,2.9.11.28).
Avere il dono della profezia, i doni intellettuali più alti, conoscere «tutti i misteri e tutta la scienza», compiere miracoli strepitosi in virtù di una fede intrepida (cf. Mt 17,20; 21,21), anche queste cose non hanno valore. La risposta dell’Apostolo è ancora più decisa della precedente: chi ha questi carismi, senza l’amore-agape, non è nulla (cf. Mt 23,16; 1Cor 7,19; 2Cor 12,11). Eppure la capacità di edificare di questi doni rispetto alla glossolalia è più grande: il profeta, chi ha il dono della scienza, il taumaturgo possono produrre frutti reali in seno a una comunità. Ma a Paolo non sembrano interessare questi effetti; se a costoro manca l’amore-agape, questi carismatici sono spiritualmente zero.
Il v. 3 si riferisce ai carismi dell’assistenza (cf. 12,28). L’Apostolo usa come terza esemplificazione l’impegno di quei cristiani che, senza esitare, donano tutto quello che possiedono e spendono se stessi, senza riserve, per il bene dei loro fratelli. Anche questo non è forse ammirevole?
Questa generosità straordinaria non è forse gradita agli occhi del Signore (cf. 1Gv 3,17)? «E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato», esprime una forma estrema ed eroica d’amore. Il verbo greco tradotto con “distribuire” significa ridurre in pezzi o a bocconi. Non si tratta di una elemosina qualsiasi, non si tratta del superfluo (cf. Mt 6,1-5)! E’ un’altra impressionante iperbole: c’é forse qualcosa di più grande, dopo aver donato tutto ciò che si ha, del dare la propria vita (cf. 2Cor 12,15)? Dell’essere bruciati, come sovente era accaduto nella storia più recente del popolo ebraico (cf. Dan 3,19-97; 2Mac 7,3-5; 4Mac 5,32; 6,24; 9,19; ecc.)?
Ci si può consumare più di così? Eppure queste rinunce, di per sé, non servono a niente. Si avverte una punta amara di ironia nel sostenere che, nel perdere tutti i propri beni e nel consegnarsi alla morte, non si può sperare di ricavare alcun vantaggio. Manca quell’amore-agape che fa di tutto ciò un tesoro prezioso davanti a Dio. L’amore-agape è il bene sommo e l’unico necessario,
- Nei primi versetti dell’Inno (1-3), l’Apostolo mette in opposizione l’amore-agape con una serie di atti esteriori ed eclatanti che l’opinione corrente considerava l’espressione più alta del genio e della virtù. Con piglio deciso, si potrebbe dire brutale, Paolo ha dichiarato l’insignificanza di queste manifestazioni carismatiche prive dell’amore-agape. Ma questa carità cos’é? Si è indotti a pensare che si tratti di una qualità altamente spirituale, un dono divino carismatico interiore e personale, la conditio sine qua non perché il credente possa ritenersi vero discepolo, E’ quello che afferma la seconda strofa dell’Inno.
«La carità è paziente» (v. 4); in questo modo positivo e attraverso una personificazione, l’Apostolo indica la prima caratteristica, molto generale, dell’amore-agape. La pazienza è spesso lodata nei Salmi come un attributo di Dio. E’ la capacità di sottostare alle ingiurie e di subirle senza renderle (cf. Mt 5,10-11.21-24), senza adirarsi. Come dunque Dio frena la sua collera per dare ai peccatori il tempo di convertirsi (cf. Rm 2,4; 9,22), così i figli di Dio devono vincere e superare i loro risentimenti, spegnere il loro desiderio di vendetta. E’ una vittoria che non si ottiene senza molto amore e umiltà (cf. 2Cor 6,6; Gal 5,22; Col 3,12; ecc.), tanto più che la pazienza cristiana si deve esercitare verso tutti e in tutte le forme possibili (cf. 1Tess 5,14; Col 1,11).
Essa suppone forza d’animo, dolcezza e mansuetudine; in essa non c’é mai acredine, non c’é mai disperazione, ignora le recriminazioni e la permalosità. La pazienza ha il senso del dono gratuito di sé. Dando all’amore-agape per primo questo carattere, l’Apostolo vuole sottolineare questo aspetto di grandezza d’animo che sarà completato dall’affermazione successiva. Se l’amore-agape è paziente in tutte le circostanze più comuni della vita, spesso difficili, questo non può essere che per partecipazione, in virtù dello Spirito (cf. Gal 5,22), alla pazienza di Dio nell’imitazione di Cristo.
Paolo poi dice che «è benigna la carità». Il greco evoca anzitutto l’idea di nobiltà e di eccellenza, poi di benevolenza, di affabilità e di liberalità. Suggerisce inoltre l’idea di accoglienza, un’accoglienza delicata e generosa del cristiano verso il suo prossimo. La benevolenza fa del cristiano una persona servizievole, che sa rendersi utile, che sa prevenire le necessità altrui con l’aiuto, l’amabilità, il sorriso. Per questo si comprende come la benevolenza sia uno dei tratti più espressivi dell’amore-agape e completi ciò che il termine “pazienza” aveva di passivo, confermando l’idea di grandezza d’animo che essa supponeva.
«Non è invidiosa la carità», continua l’Inno. Dopo la duplice annotazione sul carattere magnanimo e generoso dell’amore-agape, va da sé che gli sono estranee tutte le meschinità della gelosia. In più, amare dice contentezza e bontà, mentre l’invidia è essenzialmente tristezza; poi, come per la sua pazienza e affabilità l’amore-agape facilita i rapporti fraterni, al contrario la gelosia opera separazioni, crea distanze, non accetta la diversità. Per la sua apertura verso l’animosità e la collera la gelosia si oppone radicalmente alla pazienza dell’amore-agape. Scritte in particolare alla chiesa di Corinto, le parole di Paolo rimandano eloquentemente al problema delle fazioni che si erano delineate al suo interno (cf. capp. 1-4).
Nelle parole «(la carità) non si vanta», a causa di un verbo greco tardivo, poco usato e difficilmente circoscrivibile, si avvertono varie sfumature. Esso contiene l’idea di una certa sregolatezza di spirito, di una certa mancanza di misura che si traduce in arroganza, in parole sconsiderate che oscillano dalla frivolezza all’insolenza. L’amore-agape è esattamente il contrario di tutto questo. Esso comporta un giudizio di apprezzamento e di stima. Di per sé l’amore-agape è ponderato, non abusa dello slogan “tutto è permesso” (1Cor 6,12; 10,23), è alieno dall’infatuazione per i carismi più spettacolari (cf. 1Cor 12,14-17.21-26), non si lascia sedurre dall’ostentazione e dalla millanteria. Si evidenzia di nuovo come la carità stia insieme all’umiltà (cf. 2Cor 12,9; Fil 2,3s.), ignori l’ambizione e la vanagloria. Essa non agisce mai in modo sconsiderato.
L’ultima considerazione sull’amore-agape del vers. 4 è che esso «non si gonfia». Entra in scena l’orgoglio. Paolo ha di mira la vanità di persone pie, religiose e poco intelligenti che si stimano virtuose o favorite da doni celesti e che fanno sentire il peso della loro superiorità o dei loro privilegi religiosi. E’ in questo modo che i corinzi cercano di rivaleggiare in conoscenza, in glossolalia o in una qualche eccellenza immaginaria (cf. 1Cor 4,18-19; 5,2). E’ come se si riempissero di vento: la loro grandezza è fatta di vuoto. L’amore-agape non è così. Esso è vero, solido, non offende alcuno e sa mettersi ai livelli più umili.
Il versetto 5 inizia dicendo che la carità «non manca di rispetto». Essa evita cioè tutto ciò che può provocare choc o scandalizzare. L’Apostolo condanna la mancanza di tatto e di riguardo nei rapporti fraterni (cf. 1Cor 11,4-6). L’amore-agape che ha alla base il rispetto è di una delicatezza estrema, di una grande cortesia, ha il gusto dell’ordine e della buona creanza sia nelle riunioni comunitarie, come nelle assemblee liturgiche (cf. Rm 13,13; 1Cor 14,40; 1Tess 4,12).
Il sostantivo greco tradotto con «mancanza di rispetto» è inteso frequentemente come mancanza di onore, come furberia o grossolanità, e persino di indecenza grave (cf. Rm 1,27). S. Paolo ha senza dubbio di mira le ingiustizie commesse nella comunità di Corinto e i processi contestati davanti a tribunali pagani (cf. 1Cor 6,1-11), il caso d’incesto (1Cor 5,1-6), l’insensibilità e le ubriacature dei fedeli durante le celebrazioni eucaristiche (cf. 1Cor 11,21-22).
L’amore-agape invece ha un vivo senso dell’onore ed è molto esigente sulla limpidezza dei comportamenti.
La carità è disinteressata, «non cerca il suo interesse». Siamo sulla stessa lunghezza d’onda di Mt 5,38-42 in cui il Signore chiede di rinunciare ai propri giusti diritti. L’Apostolo stesso ricorda di aver rinunciato ai diritti conferitigli dalla sua condizione di evangelizzatore (cf. 1Tess 2,9; 2Tess 3,8; 1Cor 9,15; 2Cor 9,9s.) e può chiedere ai fratelli di essere imitato, di subire l’ingiustizia piuttosto che arrecarne ai fratelli (cf. 1Cor 6,35). In pratica questa dimenticanza totale di sé è rara (cf. Fil 2,4) perché l’amore-agape è raramente perfetto. Ma la regola è assoluta, s. Paolo l’aveva ricordato: «Nessuno cerchi l’utile proprio, ma quello altrui» (1Cor 10,24). E’ necessario che nei rapporti fraterni si pensi più all’altro che a se stessi, è necessario sapersi offrire per favorire il bene del prossimo.
Dicendo che la carità «non si adira», l’Apostolo insiste sulle qualità di temperanza e di discrezione dell’amore-agape. “Adirarsi”, nella lingua originale, ha la sfaccettatura di irritare, esasperare. La carità conserva sempre la misura ed impedisce al cristiano di perdere il controllo di sé. Certo è
giusto indignarsi contro il male e provarne collera, ma il discepolo del Signore non sarà mai gratuitamente adirato e aggressivo, non manterrà verso il suo prossimo qualsiasi sentimento di asprezza. Se si lascia libero corso alle rivalità (cf. 1Cor 1,11-17), l’animosità si incattivisce sfociando in divisioni e rancori.Il testo continua: la carità «non tiene conto del male ricevuto». Si può comprendere in due modi:
- l’amore-agape non giudica (cf. Rm 2,3; 3,28; 8,18), non soppesa il male che scopre nel prossimo, vuole ignorarlo e in ogni caso rifiuta di condannarlo (cf. 2Cor 5,19);
- la carità non registra mai il male che è stato fatto, non lo computa (cf. 2Cor 3,5; Fil 4,8) non ne conserva il ricordo. Tutto questo è molto più dell’assenza di rancore ed è anche più del perdono perché, pur perdonando, si può conservare un certo ricordo del torto subito. In questo caso invece c’é l’oblio, avviene una cancellazione delle colpe e degli errori degli altri.
L’amore-agape non ha memoria. Le sue reazioni sono sempre nuove, piene di freschezza e di creatività, vedono il bene che c’è nell’altro col quale la carità è sempre pronta a riprendere rapporti di benevolenza e generosità.
Il versetto 6 recita «non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità». La carità così dimentica del male che le è fatto è, al contrario, estremamente attenta a quello che colpisce il prossimo. L’amore-agape non si rallegra nel vedere i nemici colpiti da qualche male, da qualche ingiustizia, mentre gli altri vedono in quelle prove una sanzione divina e la giusta ricompensa per il male commesso. Chi è caritatevole se ne affligge. Si rallegra della verità, cioè del bene e della virtù (cf. Rm 11,18; 2Tess 2,12; 3Gv 4) qualsiasi forma essi abbiano, anche presso persone antipatiche. L’amore-agape non solo se ne rallegra, ma applaude al bene e al vero, mostra di condividerlo e lo loda. E’ esattamente l’opposto dello spirito settario (cf. Lc 9,49-50) presente anche nella comunità di Corinto dove, per gelosia, i cristiani non sanno stimare e lodare questo o quel fratello possessore di un carisma che non è stato accordato a loro stessi (cf. 1Cor 12,26).
La strofa termina con quattro note positive che amplificano il bene che l’amore-agape compie nei rapporti scambievoli: «Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (v. 7). «Tutto copre» vuol dire che con il suo silenzio e la sua discrezione chi è caritatevole dissimula il male del prossimo. Invece di chiacchierarne, lo nasconde sotto un velo di silenzio, come una madre che nasconde a tutti le deficienze del proprio figlio. «Tutto crede», perché la carità, che è incline all’apprezzamento e alla stima, è orientata ad interpretare tutto in bene. Non è questione di credulità, ma di fiducia nel prossimo, di una fiducia che non sospetta delle sue intenzioni o della sua condotta.
Anche di fronte all’evidenza del male, l’amore-agape «tutto spera», rimane magnanimo, non dispera, confida nel trionfo del bene. Là dove tutte le speranze sono smentite «tutto sopporta», non si lascia deprimere dalla freddezza, dalle angherie, dall’ingratitudine, dai mali di ogni tipo. Pur rimanendo sotto un peso, resta diritto, in piedi.
Queste tre ultime annotazioni costituiscono una progressione: quando l’amore-agape non discerne con evidenza il male, crede le cose più favorevoli. Dove questa fiducia è contraddetta, spera in uno sviluppo favorevole e anche là dove la sua speranza è smentita, non si scoraggia. Questa è la forza d’animo infusa dalla carità.
III. L’ultima strofa dell’Inno (vv. 8-13) mostra come, dal punto di vista della durata, la carità è ancora una volta superiore a tutti i carismi e a qualsiasi altra virtù. Il v. 8 già lo dice «La carità non avrà mai fine»: diversamente dai carismi essa è immutabile; la permanenza è una delle sue caratteristiche diversamente dall’eros e dalla philia.
Ma si possono cogliere nell’espressione dell’Apostolo due sfumature. Da una parte l’amore-agape non smette mai di agire, ogni attività virtuosa che viene da lui non è occasionale o effimera, la carità è sempre all’opera. Dall’altra, nella sua permanenza eterna, l’amore-agape non cambia di natura e, al contrario della fede della speranza, sarà in cielo esattamente come in terra. Tutto si modifica, ma la carità rimane sempre identica a se stessa senza lasciare spazio a valori nuovi.
Paolo divide l’economia cristiana in due fasi segnate dall’antitesi “adesso-allora”, la prima, attuale e transitoria, precede la parusia e comporta l’effusione dei doni dello Spirito, l’altra, che comincerà col ritorno glorioso del Signore, sarà definitiva e perfetta, e non avrà più bisogno di conoscenza e profezia. Nella condizione presente, noi non abbiamo che un’infima conoscenza dei misteri divini, i nostri sono dati frammentari come quelli della conoscenza infantile (bambino è ripetuto cinque volte) e non possiamo che balbettare.
I carismi sono precisamente le facoltà provvisorie date per istruirci e aiutarci ad esprimere questi “misteri” durante questo tempo intermedio. Ma, qualsiasi essi siano, diverranno assolutamente inutili e risibili rispetto allo stato adulto, perfetto della vita cristiana che si caratterizzerà per una conoscenza luminosa e consumata di Dio faccia a faccia. Al contrario, l’amore-agape che è nel cristiano sulla terra, sussisterà nel mondo futuro ed avrà una sua ultima attività o il suo frutto: conoscere Dio.
Questa diversità di conoscenza viene espressa attraverso l’esempio dell’immagine nello specchio e del vedere faccia a faccia. Corinto era famosa per la fabbricazione di specchi metallici. Gli specchi antichi, spesso concavi o convessi, e raramente realizzati alla perfezione, non davano in nessun modo un’immagine perfettamente nitida e precisa della persona che vi si rifletteva.
La difficoltà non sta però nel comprendere questo inconveniente, ma nell’identificare il senso dello specchio in sé. Fra le molte ipotesi, la più attendibile è quella che riconduce all’ambiente ebraico, e precisamente a Filone. Questi, nell’opera “De Decalogo”, dice che il mondo è lo specchio di Dio e, attraverso di lui, si può giungere a una certa conoscenza della divinità. E’ lo stesso insegnamento di Rm 1,20 come di tutto l’A.T.: non si può conoscere Dio direttamente (cf. Es 33,20). Dunque Paolo oppone alla visione faccia a faccia quella di uno specchio, la realtà al riflesso della realtà.
A questo carattere indiretto, e perciò inferiore della conoscenza attuale di Dio, s.Paolo aggiunge poi una nota peggiorativa: vediamo «in maniera confusa», (en ainìgmati), in modo oscuro. Se la conoscenza attraverso lo specchio è di per sé indiretta, essa è anche poco chiara. Dire questo non è ripetere due volte la stessa cosa (cf. Nm 12,6). Se ne deduce che i fenomeni carismatici della chiesa di Corinto sono un modo ancora imperfetto e notturno della conoscenza di Dio; riconoscere il carattere miracoloso della conoscenza e dalla profezia nella chiesa è sottolineare ancora una volta la sua imperfezione congenita: essa non è altro che un riflesso e ancora molto oscuro.
Tutto il versetto 12 è dedicato a distinguere visione da visione, “adesso”, «come in uno specchio, in maniera confusa», da “allora”, in cielo, «faccia a faccia». L’Apostolo non designa l’oggetto di questa visione, ma parla soltanto del suo modo, non più sensibile, ma spirituale. Anche se non è possibile penetrarne il mistero s. Paolo in qualche modo ne rende conto dicendo: «conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto». La nostra conoscenza celeste sarà funzionale a quella che ha Dio di noi. La conoscenza umana sarà portata a livello della conoscenza divina e, poiché essa ne sarà dipendente, le sarà in qualche modo assimilata e della stessa natura (cf. 1Cor 8,3). D’altra parte in cielo non ci sarà più la conoscenza (cf. v. 8), conoscere sarà un ricordo, se si può dire così.
La conoscenza nella sua forma compiuta non sarà semplicemente una percezione meno perfetta della natura divina e dei suoi attributi, ma una conoscenza pratica che, nel senso biblico del termine, sta per una possessione. L’eletto “comprende” Dio, lo afferra, entra in comunione di vita con lui, esattamente come Dio lo ha conosciuto e preso, l’ha fatto suo per amore (cf. Fil 3,12). Secondo i versetti 8 e 13 questa conoscenza-possessione divina nel mondo futuro sarà intimamente legata all’amore-agape.
«Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!»(v.13). L’Apostolo che ha esaltato in modo così grande la carità al di sopra dei carismi, non può che mettere implicitamente in discredito le due grandi virtù della fede e della speranza, ed è per una preoccupazione pastorale e catechetica che egli le ricorda come inseparabili dall’amore-agape. Il versetto 13 è un passaggio di conclusione del cap. 13 e di transizione al capitolo successivo che riporta alla situazione concreta della chiesa di Corinto.
Se i carismi sono un elemento accessorio mentre la carità è essenziale, quest’ultima non è tutto; le sue componenti o le sue funzioni maggiori possono essere distinte in una triade: fede, speranza e amore-agape. I credenti camminano nella fede, lontano dal Signore (cf. 2Cor 5,6-7), ma tesi verso una pienezza gioiosa (cf 1Cor 1,7-9), vivendo in quell’amore che disciplina tutta la loro vita morale (cf. vv. 4-7). Queste tre forze sono così strettamente connesse, che la loro attività è segnalata dal verbo “rimanere” al singolare (vedi il greco). Questo significa che le virtù teologali, che sono le sole a definire propriamente la vita morale (cf. 1Tess 1,3; 5,8; ecc.), sono stabili, ma anche di un ordine diverso, superiore all’attività transitoria dei carismi, doni passeggeri che non abitano definitivamente il cuore di un figlio di Dio.
Questa sfumatura, questa gerarchia di valori, rende conto dell’ultima precisazione: «ma di tutte più grande è la carità!». Sicuramente le tre virtù, spesso confuse una per l’altra, costitui-scono i veri valori spirituali della vita cristiana; ma delle tre la carità è la più grande. In che senso è la più grande? Nel senso già detto poco sopra: lo è perché lei sola sussisterà nel Regno dove assicura la visione e la comunione definitiva con Dio.
La sua eccellenza, pur svelandosi fin d’ora, è anzitutto escatologica. E poi può essere verosimile che l’Apostolo chiuda quest’Inno, di ispirazione così fortemente evangelica, con un riferimento a un detto (loghion) del Signore abbondantemente citato dalla tradizione e che doveva servire come base alla catechesi di tutte le chiese (cf. Rm 13,10). Se la carità è al di sopra di tutto è perché il Cristo 1o ha dichiarato facendone l’oggetto del «primo e più grande dei comandamenti» (Mt 22,38). Da qui l’imperativo dell’amore: «Ricercate la carità» (14,1), che è la conclusione pratica, così come retorica, di tutto il capitolo 13.
- 7. Osservazioni conclusive – E’ incontestabile che 1Cor 13 metta l’accento sull’amore del prossimo. Non c’é nessun versetto che costringa a intendere l’amore-agape come amore verso Dio. Poi non porta fuori da questo rilievo associare l’amore fraterno alle virtù della fede e della speranza, e neppure nel dichiarare la superiorità della carità (v. 13). Nondimeno crea difficoltà pensare che l’amore del prossimo non cadrà, ma durerà in eterno. L’amore per Dio è senza dubbio presupposto, ma non è ad esso che pensa prima di tutto s. Paolo.
Di che natura è questo amore-agape? L’Apostolo inizia a parlarne designandolo come “via” (12,31), termine che biblicamente indica il comportamento morale, ma aggiungendo che si tratta più di una disposizione interiore che di un’attitudine esteriore. Il termine agape e il dinamismo straordinario di questo amore mostrano che non si tratta di un sentimento, che non ha nulla a che vedere con l’emotività. La forza che lo caratterizza fa pensare piuttosto a una virtù, anche se questo termine non piace molto a s. Paolo perché ricorda troppo lo stoicismo.
Il confronto fatto con i carismi (cf. 1Cor 12,31; 14,1) assicura che è un dono di grazia, un dono dello Spirito (cf. Rom 5,5; 15,30; Gal 5,22; Col 1,8; 2Tim 1,7). Però è talmente superiore ai carismi che bisogna superare anche questa categoria e intravedere una potenza di origine divina, una partecipazione alle forze del mondo futuro (cf. Eb 6,5). Di fatto è la sola realtà di quaggiù che sussisterà al di là della morte. Bisogna concludere che l’amore fraterno è essenzialmente dipendente dall’amore di Dio.
Questo è forse l’insegnamento più importante di questo capitolo. L’agape è una potenza, è una pienezza e per questo è radicalmente distinta dall’eros. Nel cap. 13 della 1 Corinzi è l’amore cristiano del prossimo, cioè un amore che non proviene dalla carne e dal sangue. Esso è donato da Dio, o meglio ancora, è effetto e partecipazione all’amore con cui Dio conosce e ama gli uomini. Ecco il perché della sua tendenza; la sua natura stessa è quella di volere il bene del prossimo e di impegnarsi per esso. Ecco perché è così generoso, gratuito, universale, eterno. Ecco perché l’Apostolo insiste tanto sulla sua trascendenza e assolutezza. Ecco perché non c’é discontinuità fra l’amore di Dio e l’amore del prossimo, non c’è antagonismo o divergenza: l’agape è unico, lo stesso nella sua scaturigine, lo stesso nei suoi destinatari.
L’amore-agape è l’unico valore religioso, il tutto del cristianesimo. Senza di esso il cristiano non fa nulla che valga (cf. v.1), non guadagna niente per se stesso (cf. v. 3), non vale nulla (cf. v. 2), senza di esso è inesistente come discepolo. Si può dunque considerare l’agape come l’anima e la vita del credente nel senso più proprio della parola. Se il cristiano non può esistere senza la carità, egli non può essere in Cristo se non perché ama (cf. Gv 13,35).
- Paolo non definisce questa attività astrattamente, né in rapporto a una legge scritta. Ne parla come libertà, come spontaneità sorgiva. Quindici verbi esprimono qualcuna delle sue manifestazioni concrete (cf. vv. 4-7). Il verbo “amare” (agapàn), significando essenzialmente un amore giudizioso, non meraviglia se si manifesta prudente, riflessivo, circospetto, non sorprende se dà una misura perfetta a tutte le azioni del credente. Disinteressato, l’amore non può che favorire la giustizia e indignarsi di ogni insidia al diritto altrui. Questo comportamento è pervaso di nobiltà come di delicatezza e di dolcezza. Ma il dinamismo dell’agape si rivela soprattutto nella magnanimità e nella fortezza. L’agape, in azione, è il dispiegamento di una forza divina che sottomette a sé i sentimenti e le passioni dell’uomo per orientarli al bene del prossimo. Nel pensiero di Paolo si può definire il cristiano per il solo amore-agape: il cristiano è un uomo che ama il suo prossimo.
Fra tutti vi sono tre tratti caratteristici: senso dell’onore e della grandezza, una dolcezza piena di delicatezza e di tatto, infine una volontà di discrezione e di misura in tutte le cose. Se i carismatici possono essere a volte infiammati e spesso inopportuni, chi vive nell’amore-agape è silenzioso e paziente. L’agitazione sulla terra cesserà, le lingue taceranno, ma l’agape contemplerà Dio senza parole, più esattamente, Dio lo illuminerà e chi è caritatevole sarà pura ricettività di questa luce e di questo amore.
NB – Per questo commento mi sono servito molto di uno studio documentatissimo di C.Spicq, Agape dans le Nouveau Testament, Analyse des textes II, Paris 19663 53-120.