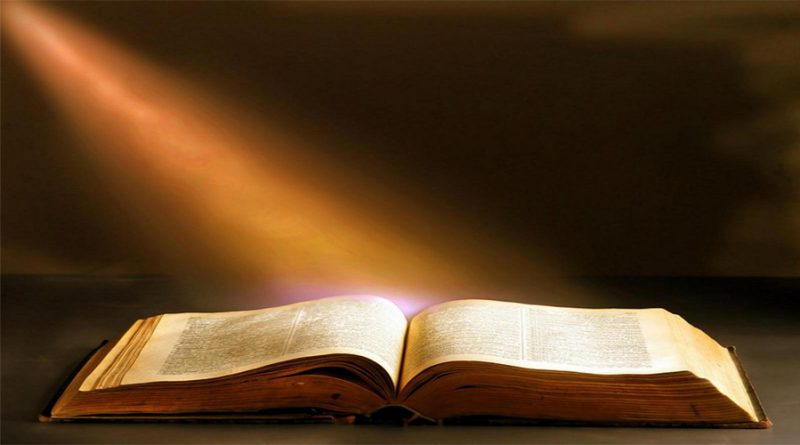L’eredità della “Dei Verbum”
 Luca Mazzinghi
Luca Mazzinghi
Trascrizione di conferenza non rivista dall’autore
1. Introduzione
Per festeggiare il 25° anno di fondazione del C.I.B., si è pensato come argomento alla Costituzione dogmatica “Dei Verbum” (DV), per un motivo quasi obbligato: tra alcuni mesi inizieranno le celebrazioni per i 50 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II (CV II). Allora, parlando a persone che hanno sempre messo la Bibbia al centro della propria attività, si è creduto che riscoprire «L’eredità della “Dei Verbum”» potesse essere utile per celebrare questo 25° anniversario.
In effetti, al cuore del Concilio c’è stata proprio la riscoperta della Scrittura. Se si dovesse indicare qual è stata una delle principali novità del Concilio, si potrebbe segnalare senza dubbio proprio questa: la riscoperta della Bibbia. In ciò il CV II ha operato quella che mons. Luigi Bettazzi, nel suo bel libro del 2006 sull’eredità del Concilio “Non spegnere lo Spirito – Continuità e discontinuità del Concilio Vaticano II”, definisce «una vera e propria rivoluzione copernicana». Ovviamente non è l’unica che il CV II abbia operato; tuttavia è possibile mostrare come tutte le altre rivoluzioni conciliari siano legate alla riscoperta delle Scritture.
Si pensi, ad esempio, alla riflessione sulla Chiesa intesa come «popolo di Dio» (si legga “Lumen Gentium” (LG) al cap. III), col rovesciamento di una visione di Chiesa centrata sulla gerarchia prima che sul popolo di Dio.
Si pensi alla teologia dei “segni dei tempi”, che la costituzione pastorale “Gaudium et Spes” (GS) riprende da papa Giovanni XXIII. Si ricordi la celebre frase di GS 4: «È dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo». Era ciò che aveva già affermato papa Giovanni XXIII nell’enciclica “Pacem in terris” (1963). E questa teologia fa nascere un rapporto di dialogo tra Chiesa e mondo. La Chiesa non è più la “societas perfecta” che deve difendere la verità rivelata contro il relativismo, il laicismo e tutti gli altri “ismi” esistenti. È piuttosto, in positivo, il popolo di Dio che è «segno e strumento della comunione di Dio con gli uomini», come insegna LG 1. Con questo mondo, nel quale essa stessa vive, la Chiesa instaura un dialogo di salvezza.
La teologia dei “segni dei tempi” è profondamente biblica e permette di guardare al mondo con speranza e non col desiderio di ergersi a difensori della verità e a giudici di un mondo che non è capace di accoglierla. Poiché, appunto, si avvicina l’anniversario del Concilio, occorrerebbe leggere il discorso di apertura del CV II, che papa Giovanni XXIII tenne il giorno 11 ottobre 1962. Il Santo Padre scrive solennemente che «a Noi sembra di dover dissentire da codesti profeti di sventura» che nel mondo contemporaneo vedono soltanto ciò che si oppone a Dio. E afferma di volervi leggere piuttosto i segni della sua presenza, ossia quel «nuovo ordine di rapporti umani» verso il quale la Provvidenza sta conducendo il mondo: «Nel presente momento storico, la Provvidenza ci sta conducendo ad un nuovo ordine di rapporti umani, che, per opera degli uomini e per lo più al di là della loro stessa aspettativa, si volgono verso il compimento di disegni superiori e inattesi; e tutto, anche le umane avversità, dispone per il maggior bene della chiesa». È di questo spirito, che è profondamente biblico e che nasce dal CV II, che la Chiesa ha ancora bisogno.
Un altro aspetto di novità del Concilio che nasce dalla Bibbia è il rinnovamento liturgico con la riforma della liturgia, sebbene in realtà il documento sulla liturgia, ossia la “Sacrosanctum Concilium” (SC) sia il meno “conciliare” dei documenti, in quanto fu il primo ad essere pubblicato. Dunque si vede che si era agli inizi di un percorso ancora in germe. Eppure anche nella SC, rivoluzionando pure in questo caso l’impostazione liturgica tipicamente tridentina, la Scrittura viene posta al centro dell’azione liturgica. È sufficiente leggere SC 7: «Cristo è presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura». Nel 1962 queste non erano idee ovvie.
Ancora la SC: «Allo scopo di favorire la riforma [liturgica], il progresso e l’adattamento della sacra liturgia, è necessario che venga promossa quella soave (che bell’aggettivo!) e viva conoscenza della sacra Scrittura, che è attestata dalla venerabile tradizione dei riti sia orientali che occidentali» (SC 24). Tra l’altro, queste righe smentiscono coloro che sostengono che il CV II non parla di “riforma”: invece ne parla molto spesso e in maniera esplicita.
Qui a noi interessa fermarci sulla novità che nasce dal secondo documento dogmatico del CV II. Il primo documento dogmatico è la “Lumen Gentium”; il secondo è la “Dei Verbum” (promulgata da Papa Paolo VI il 18-11-1965), che nella recente esortazione apostolica “Verbum Domini” (VD) di papa Benedetto XVI del 2010 è ricordata fin dall’inizio (al n. 3) come il punto fermo della riflessione della Chiesa sulla Scrittura negli ultimi 50 anni. A titolo di esempio, è sufficiente ricordare che la teologia dei “segni dei tempi” appena richiamata trova il suo fondamento nell’idea di rivelazione esposta nel testo capitale di DV 2. Dove, inoltre, si introduce anche un’altra rivoluzione che è evidente a chi confronti DV 2 col testo della precedente costituzione dogmatica del Concilio Vaticano I (CV I), ossia la “Dei Filius” (DF).
2. Prima della “Dei Verbum”
Per capire cosa la DV dice e come lo dice, è importante conoscere lo sfondo sul quale essa nasce. Per fare ciò, bisogna compiere un passo indietro e guardare quali erano i problemi dibattuti alla fine degli anni ’50 e agli inizi degli anni ’60 in relazione alla Scrittura; e in che modo il Concilio li ha affrontati e risolti. I problemi principali erano tre.
1. Il primo problema che i padri conciliari dovettero affrontare era sicuramente quello del rapporto tra Scrittura e tradizione, un rapporto che – come noto – era stato messo in crisi dalla riforma luterana e sul quale il Concilio di Trento (XVI secolo) aveva lasciato la questione in sospeso. I padri di Trento avevano scartato una formula che intendeva la rivelazione come contenuta «partim in libris scriptis et partim in sine scripto traditionibus». Questa formula “in parte… in parte…” era stata, appunto, scartata a favore di una formula che non pregiudicasse una futura soluzione del problema. I padri di Trento furono lungimiranti e scelsero di affermare che le verità rivelate si trovano «in libris scriptis et in sine scripto traditionibus». Quindi non “partim… partim…” (che sarebbe stato quasi un disastro teologico), bensì “et… et…”, formula che non risolve il problema, ma almeno lo precisa.
Alle soglie del CV II il problema si ripresentò in tutta la sua drammaticità. Su questo punto il dibattito conciliare fu molto acceso, in particolare per gli evidenti risvolti ecumenici di tale tematica. Ma di ciò non parliamo, in quanto si tratta di un problema più teologico che richiederebbe premesse più lunghe. Comunque è un punto di partenza importante.
2. Un secondo problema presente alla fine degli anni ’50 verteva sul fatto che, negli studi biblici, si era ampiamente affermato il metodo “storico-critico”, che alla fine del XIX secolo aveva contribuito a mettere in crisi la tradizionale visione dell’inerranza biblica, cioè del fatto che la Bibbia scrive la verità. Lo sviluppo degli studi linguistici e storici, la nascita di una critica letteraria, le teorie dei generi letterari, impedivano ormai di leggere la Bibbia come un testo privo di errori e da prendersi storicamente per buono.
Era però ancora viva l’eco dei decreti della “Pontificia Commissione Biblica” del 1906 e del 1909, che difendevano la storicità fattuale di Gen 1-11 (per cui, ad esempio, Adamo ed Eva sarebbero storicamente esistiti) e proclamavano, ormai anacronisticamente, l’autenticità mosaica del Pentateuco. Tutto ciò nonostante il fatto che, alla fine degli anni ’50, si cominciasse a respirare un clima nuovo, grazie alle notevoli aperture operate da papa Pio XII, in particolare alla luce dell’importantissima enciclica “Divino afflante Spiritu”, pubblicata nel 1943, di cui poco si erano sentiti gli effetti a causa della Seconda Guerra Mondiale in corso.
Il problema non era più soltanto una questione di metodo. I cattolici più attenti e preparati non riuscivano più ad accettare una lettura fondamentalista della Scrittura, arroccata su principi ermeneutici ormai palesemente indifendibili. Non bisogna dimenticare che, proprio alla fine degli anni ’50, il “Pontificio Istituto Biblico” di Roma fu oggetto di attacchi violenti da parte di autorità vaticane, fino ad arrivare, già sotto papa Giovanni XXIII nel 1962, alla sospensione di due santissimi professori (padre Max Zerwick e padre Stanislas Lyonnet), che l’anno successivo Paolo VI, appena divenuto papa, reintegrò nell’insegnamento. Si legga a tal riguardo l’istruttiva storia del Pontificio Istituto Biblico (“Il Pontificio Istituto Biblico – Un secolo di storia”, 2009), pubblicata da padre Maurice Gilbert, che ne è stato a lungo rettore.
3. Un terzo aspetto problematico era relativo allo sviluppo, sempre più massiccio, di quello che è stato chiamato il “movimento biblico”. Nel secondo dopoguerra, all’interno della Chiesa cattolica l’attenzione alla Scrittura era cresciuto in modo sempre più marcato, sebbene da buona parte della gerarchia ecclesiastica lo studio della Bibbia fosse visto con un certo sospetto. Non bisogna dimenticare come, a partire dalla riforma luterana del XVI secolo, le proibizioni magisteriali contro la lettura della Bibbia erano andate moltiplicandosi, soprattutto dalla fine del ‘600, coi decreti post-tridentini. È inutile soffermarsi su questi tristi capitoli; è sufficiente ricordare che, dopo il Concilio di Trento, la lettura della Bibbia – purché in latino e nell’edizione ufficiale della “Vulgata” di Girolamo; anzi, meglio ancora era la “Sixto Clementina” (ossia l’edizione Vulgata latina del 1592, preparata da Papa Clemente VII) – era permessa, come stabilisce il decreto post-tridentino, «viris tantum doctis». Qui «viris» va inteso in senso proprio, ovvero i maschi: «Soltanto ai maschi dotti». La lettura privata della Scrittura in volgare era esplicitamente vietata.
A tal proposito si può leggere il libro di Gigliola Fragnito: “La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)” (1997), molto istruttivo su questo periodo storico.
Per quanto riguarda l’Italia, bisognerà attendere la fine del 1700 per avere una traduzione cattolica della Bibbia, che però non era dai testi originali, bensì dal latino. Era quella del card. Antonio Martini (1720-1809), arcivescovo di Firenze. Tale traduzione nacque, però, a Superga, del cui Collegio Martini fu direttore per un certo periodo. Non solo: fu pubblicata unicamente poiché Martini aveva il forte appoggio dei Savoia, che lo sostenevano anche politicamente e che quindi gli permisero di ottenere il permesso per questa vera e propria novità.
Sarà soltanto nel 1757 che la Santa Sede permetterà di tradurre la Bibbia latina nelle lingue volgari. Però in Italia le prime traduzioni dai testi originali giungeranno soltanto negli anni ’50 del XX secolo. Da questi pochi dati si intuisce che il problema era molto serio.
3. La genesi della “Dei Verbum”
È ben nota la vicenda, insieme appassionante e drammatica, che ha portato alla nascita della DV. Rimandiamo i più curiosi alla fondamentale opera in più volumi di Giuseppe Alberigo sulla “Storia del Concilio Vaticano II”; e, più in particolare, anche al libro di Riccardo Burigana sulla genesi della DV: “La Bibbia nel Concilio – La redazione della costituzione «Dei Verbum» del Vaticano II” (1998).
Il 14 novembre 1962, pochi giorni dopo l’apertura del CV II, fu presentato ai padri conciliari lo schema “De fontibus revelationis”, schema dietro al quale stava l’opera del card. Alfredo Ottaviani (1890-1979), che riprendeva in realtà la formulazione della DF del CV I. Però peggiorava la situazione, in quanto inaspriva ancor di più i problemi ricordati in precedenza.
Dopo una settimana di intense discussioni (un altro segno della novità del Concilio: si discuteva, qualche volta fino al limite della rottura), la votazione su questo schema rappresentò uno dei momenti chiave dell’inizio del CV II. Su 2.209 padri votanti, 822 si dichiararono contrari allo “schema Ottaviani”, non raggiungendo però i 2/3 necessari a bocciarlo secondo le regole conciliari. Quindi il Concilio rischiava di spaccarsi quasi in due proprio nella settimana in cui era iniziata la discussione.
Qui ci fu uno dei grandi gesti di papa Giovanni XXIII, che intervenne di persona: ribaltò il voto conciliare e – cogliendo lo spirito degli 822 che avevano votato contro lo “schema Ottaviani” – rimandò lo schema alla commissione, imponendole un radicale rinnovamento. Fu un gesto di grande apertura e di grande coraggio. E fu l’inizio di un complesso cammino che, dopo ben tre anni di studi e di dibattiti anche intensi, di lavori sulla tradizione e sulla Scrittura, di ricerca di accordi che non spaccassero la Chiesa su posizioni unilaterali, portò alla nascita della DV.
La posta in gioco era molto alta: era l’idea stessa di una rivelazione concepita come un corpo di verità che Dio comunica all’uomo, affinché l’uomo creda in tali verità. La DV nacque da un confronto coraggioso e aperto, che seppe mettere insieme il rispetto per la tradizione e per la Scrittura ed anche l’esigenza di un profondo rinnovamento pastorale. Non bisogna avere paura di definire tutto ciò un vero e proprio capolavoro dello Spirito Santo.
4. Dio manifesta
il mistero della sua volontà (DV 2)
A mio parere, il testo teologicamente più importante è il proemio di DV 2. Forse senza esserne pienamente coscienti, i padri conciliari hanno offerto in questo testo la chiave per comprendere l’intero documento. La recente esortazione apostolica Verbum Domini lo riafferma chiaramente: «La novità della rivelazione biblica consiste nel fatto che Dio si fa conoscere nel dialogo che desidera avere con noi» (VD 6). L’espressione «nel dialogo che desidera avere con noi» è una ripresa e, per certi aspetti, un ampliamento del testo di DV 2, che subito dopo, infatti, Benedetto XVI cita.
Veniamo allora a DV 2, che inizia così:
«Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare sé stesso e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura».
Chi ha studiato bene questo testo conciliare ricorderà che tale idea quasi capovolge la prospettiva del CV I. Ad esempio, in DV 2 manca la dimensione apologetica che si trovava nella DF.
Inoltre al primo posto non appare, come invece nella DF, l’idea di una rivelazione naturale di Dio attraverso il lume della ragione, bensì piuttosto l’immagine profondamente biblica, corroborata dal ricorso alla lettera agli Efesini (cf. Ef 1,9), del «mistero» (nell’originale latino del testo conciliare: “sacramentum”) della volontà di Dio, che rivela Sé stesso agli uomini.
Nel linguaggio paolino il termine «mistero» rimanda direttamente al progetto di Dio sulla storia degli uomini; rimanda ad un dire e ad un fare di Dio che non è riducibile alla somma di qualche verità, ma che va riferito all’azione storica di Dio, che culmina nell’evento pasquale e che, nello Spirito Santo, si rende manifesta ai credenti.
Si noti anche che il termine «mistero» usato dalla costituzione è uno dei segni più evidenti di questa svolta biblica. Infatti viene eliminata l’espressione utilizzata dalla DF, che non era «sacramentum» («mistero»), bensì «aeternae voluntatis suae decreta», che è tutt’altro discorso. Tale formula dava alla rivelazione una connotazione giuridico morale, che la DV deliberatamente abbandona.
Ancora: DV 2 inizia con la bellissima espressione: «Placuit Deo», ossia: «Piacque a Dio». Essa inserisce la rivelazione in un orizzonte di gratuità, rafforzando questa espressione con l’inversione dei termini che la DF usava. Infatti DF recitava: «Nella sua sapienza e bontà»; invece significativamente la DV preferisce: «Nella sua bontà e sapienza», mettendo dunque al primo posto la gratuità dell’amore di Dio che si rivela agli uomini.
Inoltre la DV sottolinea che la rivelazione ha un legame diretto sia con l’incarnazione (quindi con la storia nella quale il Figlio di Dio entra), sia con il dono dello Spirito (che apre all’uomo lo spazio della libertà di Dio). Infatti, continua la DV, il fine della rivelazione è che gli uomini divengano «partecipi della natura divina» (qui si citano Ef 2,18 e 2 Pt 1,4), ovvero la comunione con Dio, che è una tematica in realtà anticipata dalla citazione di 1 Gv 1,2-3 nel paragrafo precedente della DV , ossia il “Proemio” (DV 1).
5. Amici in dialogo con Dio (DV 2)
DV 2 prosegue così: «Con questa rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé». Questo testo è una delle vere e grandi novità della DV: la rivelazione ha una dimensione dialogica e amicale. Il testo originale latino parla di «conversatio» di Dio con gli uomini, riprendendo un’idea molto antica, presente negli scritti di san Bernardo (1090-1153), e ricollegandosi con una splendida pagina dell’enciclica “Ecclesiam Suam” (ES) di papa Paolo VI, che era stata pubblicata da poco (1964). Si può rileggere il capitolo III della ES sul dialogo (nn. 67-71), in cui Paolo VI afferma che l’essenza della Chiesa è il dialogo. Sono parole che oggi fanno anche stupire, poiché generalmente non si ha più questa idea della Chiesa.
Dunque la rivelazione è nell’ordine di un rapporto profondo e personale con Dio, in Cristo, «il quale è il mediatore e insieme la pienezza di tutta intera la Rivelazione», come si legge nell’ultima frase di DV 2. Per usare le parole di Benedetto XVI in VD 6: «C’è di fronte a noi un Dio in dialogo». Questa è proprio l’essenza di DV 2: un Dio in dialogo. È un concetto della rivelazione ben diverso da quello che esisteva in quell’epoca nella teologia.
La frase della costituzione: «tamquam amicos» (Dio parla agli uomini «come ad amici») in DV 2 è rafforzata da tre citazioni bibliche: due dall’Antico (AT) e una dal Nuovo Testamento (NT). Le ricordiamo.
1. Es 33,11: «Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico». Questa citazione inserisce all’interno dell’esodo e dunque al cuore dell’esperienza di Israele nel momento dell’alleanza sinaitica. Per il popolo l’esodo è un’esperienza di liberazione, è un incontro col Signore che dona la Legge; ed è una Legge che garantisce quella libertà che il popolo ha ricevuta prima della Legge.
Per Mosè l’esodo è anche un incontro personale e diretto con Dio «come con un amico», come scrive coraggiosamente l’autore del libro dell’Esodo. In tal modo è chiaro che l’alleanza non è l’alleanza della Legge, bensì è prima di tutto un rapporto personale con Dio. Non a caso il libro dell’Esodo proprio in quei capitoli parla della costruzione del santuario come il luogo di incontro con Dio.
2. Il Concilio aggiunge una seconda citazione, meno nota. È tratta dal libro del profeta Baruc. È un testo che, in realtà, viene ripreso da Paolo VI, che lo usa nell’ES a proposito della Chiesa, e che entra nella 6^ lettura della veglia pasquale: «La sapienza è apparsa sulla terra e ha conversato tra gli uomini» (cf. Bar 3,38). Il testo latino recita: «Et cum eis conversatur». In latino la “conversatio” è qualcosa di più della conversazione: è l’incontro con una persona.
Il testo di Baruc nasce probabilmente nel II secolo a.C. e la sapienza che il profeta accosta alla Legge, ossia alla rivelazione divina, appare come la rivelazione di Dio agli uomini, che non è fatta di decreti imposti dall’alto, bensì è uno scendere dall’alto verso il basso ed è un conversare insieme agli uomini. Il testo di Baruc sarà usato dal quarto evangelista, quando scriverà che questa Parola «si è fatta carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi» (cf. Gv 1,14), cioè scende tra gli uomini.
3. La terza citazione che DV 2 fa per spiegare l’espressione «tamquam amicos» è proprio dal vangelo secondo Giovanni: «Non vi chiamo più servi (…), ma vi ho chiamati amici» (Gv 15,14). Di nuovo, c’è un testo che richiama l’amicizia e il dialogo tra Dio e gli uomini. La ricerca di Gesù anima il vangelo secondo Giovanni dall’inizio alla fine. Si pensi alla domanda fatta da Gesù ai discepoli del Battista: «Che cosa cercate?» (Gv 1,38); e si pensi anche alla domanda che chiude il vangelo, posta da Gesù a Maria di Màgdala: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» (Gv 20,15). Ebbene, questa ricerca – che non è di qualcosa, bensì di qualcuno – si compie nella scoperta di un’amicizia con Gesù. È un tema che a Giovanni è molto caro, tanto che lo ricorderà anche altrove nel suo vangelo, ad esempio nel rapporto di Gesù con Lazzaro, Marta e Maria (Gv 11).
I discepoli sono gli amici di Gesù, non i suoi servi; sono gli amici per i quali Gesù non ha segreti. E il dono dello Spirito, che Gesù lascia a questi amici, è il segno del nuovo rapporto stabilito tra Gesù e i credenti in lui.
Come già accennato, DV 2 si chiude ricordando proprio la centralità del Cristo «mediatore e pienezza di tutta intera la Rivelazione». Anche questa attenzione cristologica è una grande novità rispetto alla DF.
Oggi la VD va ancora oltre: al n. 7 e ai nn. 11, 12, 13 papa Benedetto XVI ricorda che la Parola di Dio è una realtà analogica, ossia che soltanto Gesù Cristo è Parola in senso proprio. Soltanto di Gesù Cristo si può dire: Egli è realmente la Parola di Dio; il resto è una analogia della Parola. Comunque, come vedremo tra poco, questa idea di Cristo come Parola di Dio non è assente neppure dal testo conciliare.
Anche uno sguardo soltanto superficiale alle tre citazioni (Es 33,11; Bar 3,38; Gv 15,14) all’interno dell’argomentazione di DV 2 fa capire che l’argomentazione è profondamente biblica e che la rivelazione è nell’ordine del dialogo tra Dio e l’uomo come mostra la Bibbia. Dunque la rivelazione non ha come oggetto verità («aeternae voluntatis suae decreta», come scriveva la DF, ossia verità dogmaticamente codificate), ma in primo luogo è nell’ordine di un rapporto amicale, un rapporto tra persone.
In DV 5 tale comprensione personalistica della rivelazione provoca una analoga comprensione personalistica della fede: infatti con l’obbedienza della fede, prestata dall’uomo al Dio che Si rivela, «l’uomo gli si abbandona tutt’intero e liberamente prestandogli il pieno ossequio dell’intelletto e della volontà e assentendo volontariamente alla rivelazione che egli fa». La fede non esclude elementi dottrinali, ma li include in una visione tipicamente personalistica.
Un corollario interessante – lanciamo uno spunto polemico che potrebbe rivelarsi stimolante – è tratto da papa Benedetto XVI in VD 14, quando scrive che nessuna apparizione privata può essere considerata dalla Chiesa come oggetto di fede. E che in ogni caso non è obbligatorio farne uso neppure se la Chiesa la approvasse. È una conclusione molto significativa per tutti quei cattolici che, troppo spesso, antepongono alla Parola di Dio le rivelazioni della Madonna, vere o presunte che esse siano.
Il Concilio lavorava finché non veniva raggiunto l’accordo più vasto. Limava e lavorava sui documenti finché la maggioranza era la più vasta possibile. Ciò includeva, evidentemente, anche la visione delle minoranze, che in quel momento erano coloro che oggi si definirebbero i “tradizionalisti”. Per tale motivo bisogna riconoscere come, nel desiderio di evitare i contrasti e di fornire un testo che tutti potessero accogliere, comprese le minoranze, il CV II non tragga fino in fondo le conseguenze di DV 2. Così oggi è persino possibile, in nome di un’adesione talora un po’ formale e talvolta addirittura superficiale al Concilio, passare sotto silenzio questo testo, che pure resta un testo fondamentale.
6. Opere e parole di Dio
nella storia degli uomini (DV 2)
In DV 2 c’è ancora qualcosa che merita attenzione: «Questa economia della Rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto».
Qui il Concilio non cita alcun testo biblico, ma è evidente la portata biblica di questa espressione. L’idea che la rivelazione avviene «con opere e parole» fu proposta per la prima volta il 22 aprile 1964, a Concilio ben avanzato, da un piccolo gruppo di padri, dietro ai quali stava un teologo già all’epoca famoso, ovvero Yves Congar (1904-1995). Nonostante le opposizioni di molti padri, questa formula entrò nel testo finale. In latino essa suona: «gestis verbisque»; in latino «gestis» è un neutro plurale, pertanto significa «le gesta di Dio» e non «i gesti». Dunque si tratta delle grandi opere, dei «magnalia Dei» di cui la Bibbia parla spesso. Dio si rivela con le opere e con le parole.
Dietro a tale formula, in realtà, c’è anche un discorso ecumenico. Oltre che da padre Congar, questa formula fu suggerita anche da due osservatori protestanti presenti al CV II: il teologo danese Kristen E. Skydsgaard e il noto Oscar Cullmann (1902-1999), le cui idee sul rapporto tra rivelazione e storia trovarono in Paolo VI un ascoltatore estremamente attento. Ciò mostra che, in certe posizioni del Concilio, era già presente un risvolto ecumenico notevole, che all’epoca non sfuggì a chi stava attento ai risvolti teologici di questi temi.
La formula «gestis verbisque» («opere e parole») è particolarmente importante per capire ancora meglio il senso della rivelazione. Il Concilio fa sua una lunga riflessione sulla Scrittura. Già nell’AT è evidente che, quando si dice «Parola di Dio», si intende una parola creatrice. Basti pensare a Gen 1: «Dio disse: ‘Sia la luce!’. E la luce fu» (Gen 1,3); oppure al famosissimo testo di Isaia: «Come la pioggia e la neve, la mia parola non ritorna a me senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata» (cf. Is 55,10-11). Parlando, Dio crea e agisce. Per il NT si può pensare al vangelo secondo Matteo, che è costruito alternando cinque grandi discorsi di Gesù a cinque grandi narrazioni sui segni da lui compiuti. In tale modo i discorsi illuminano i segni e i segni garantiscono la realtà dei discorsi di Gesù.
Già Tommaso d’Aquino (1225 ca-1274), nella sua “Summa Theologiae”, ricordava che «dicere Dei est facere»: lo aveva ben compreso anche a livello filosofico. E aveva ben compreso, senza sapere bene l’ebraico, che nel termine ebraico “davàr” (ossia “parola”) c’è la parola, ma anche il fatto, poiché “davàr” significa sia “parola” che “fatto”.
Il capitolo aperto dal questa piccola espressione della DV «gestis verbisque» (sono quelle piccole perle che vanno sempre colte all’interno di una trattazione conciliare) è un capitolo che, ancora oggi, può essere esplorato con molto frutto. Se la storia, e non solo la parola, è rivelatrice, allora la storia del nostro tempo parla ancora agli uomini di oggi. Ecco di nuovo la teologia dei “segni dei tempi”, inaugurata da papa Giovanni XXIII e fatta propria dal Concilio. La storia del mondo non è storia di disastri, ma storia di salvezza. E il credente ha il compito di scoprire la presenza di Dio nella storia, come la Bibbia insegna.
Inoltre la connessione profonda, nella rivelazione, tra eventi e parole richiama anche l’unità della fede con la vita, che sta alla base del programma pastorale del Concilio. Si pensi a GS 43, che afferma che uno dei guai peggiori del nostro tempo – e queste parole valgono ancora oggi dopo tanti anni – è la frattura tra fede e vita, che il Concilio recupera anche a livello teologico: «La dissociazione tra la fede che professano e la loro vita quotidiana, va annoverata tra i più gravi errori del nostro tempo».
Infine, la connessione tra eventi e parole ha conseguenze fondamentali nel campo della catechesi. C’è stata quella “rivoluzione copernicana” che fu il rinnovamento della catechesi, segnato dal documento della CEI del 1971 intitolato proprio “Il Rinnovamento della catechesi”, che ha appunto rivoluzionato la catechesi in Italia. Il principio di fondo è che la catechesi deve essere fedele a Dio, ma fedele anche all’uomo, poiché Dio Si rivela nella storia degli uomini. Pertanto la storia degli uomini è protagonista e non soltanto oggetto dell’agire di Dio. La storia degli uomini è anche soggetto, in quanto luogo teologico dove Dio Si rivela. Così la catechesi non è più istruzione intellettuale, ma comunicazione interpersonale all’interno di una storia nella quale Dio Si rende presente.
In tal modo abbiamo mostrato come il dettato conciliare ha conseguenze in tutti i campi della vita della Chiesa.
Inoltre, con la connessione tra gesti e parole che il Concilio illumina molto bene (i gesti fondano le parole e le parole spiegano le gesta di Dio), si evita una concezione fattuale della storia della salvezza. Con “fattuale” si intende che la storia della salvezza sarebbe tale solamente se storicamente vera. Quindi si cerca a tutti i costi di difendere, anche contro ogni evidenza, la storicità delle Scritture. Era un atteggiamento apologetico che caratterizzava gli anni prima del Concilio e che oggi riappare da più parti, spesso sostenuto da veri e propri muri di ignoranza teologica. Infatti chi tiene questa posizione teme che, se anche solo un piccolo particolare contenuto nella Bibbia non è accaduto, salta l’intera Scrittura. Invece non si comprende che la storia della salvezza è sempre interpretata dalla parola. E pertanto il legame è a doppio senso: la parola interpreta la storia e la storia fonda la parola.
Dunque nella Scrittura sono presenti non cronache, bensì interpretazioni della storia, che proprio per questo diventano interpretazioni salvifiche.
Tale formula salva anche da un altro rischio: quello dell’idolatria della parola. È il rischio che oggi corrono molte denominazioni di matrice evangelica, soprattutto provenienti dall’America. Dio Si rivela nella parola e nella storia. E, se Si rivela anche nella storia, qui si apre il capitolo della “tradizione”, ossia il capitolo della grande tradizione ecclesiale, pure nella quale Dio Si rivela. La parola non è un assoluto che può essere sganciato dal suo legame connaturale con la tradizione.
Ricordiamo che, per la DV (e qui si risolve il problema tridentino a cui si accennava all’inizio), c’è una sola fonte della rivelazione, cioè la scrittura e la tradizione, che non sono più un “et…et…” o un “partim… partim…”, bensì un’unica fonte della rivelazione. È questa la grande novità contenuta in DV 8, 9 e 10.
Dunque la rivelazione cristiana non è un mito atemporale o qualcosa assolutamente privo di fondamento storico. È invece qualcosa che si inserisce in una tradizione viva, quella della Chiesa.
7. L’interpretazione della Scrittura (DV 12)
Questo porta direttamente a DV 12, ossia al capitolo dell’interpretazione della Scrittura, che è altrettanto vitale.
Abbiamo sottolineato che, all’inizio degli anni ’50, il problema del rapporto tra esegesi e teologia diventava sempre più grande. E che ormai si rendeva urgente sottolineare come si dovesse studiare la Bibbia. Questo problema è ancora oggi enorme, se si pensa che non è raro sentire affermazioni quali che l’esegesi non serve, così come non serve studiare, poiché basta pregare.
Innanzi tutto queste sono eresie formali: sono vere e proprie eresie a livello di magistero della Chiesa.
Ma è anche l’illusione spaventosa che la Bibbia sia un testo per il quale, una volta che il credente ci ha messo la sua preghiera, tutto si aggiusta. Ciò significa negare 2.000 anni di tradizione della Chiesa, a cominciare dai Padri della Chiesa, che studiavano tantissimo la Bibbia! Per rendersene conto, è sufficiente leggere un qualunque testo di un qualunque Padre della Chiesa, sebbene i metodi fossero ovviamente diversi da quelli di oggi.
Allora cosa significa affrontare la Bibbia?
La soluzione inizia a essere fornita in DV 12, che pone solamente il problema. Problema che verrà risolto da un altro documento fondamentale, “L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa”, edito nel 1993 dalla Pontificia Commissione Biblica, con prefazione di papa Giovanni Paolo II e dell’allora Prefetto della “Congregazione per la dottrina della fede” e Presidente della Commissione Biblica, ovvero Joseph Ratzinger. Si tratta di un documento interamente dedicato all’esegesi e all’ermeneutica delle Scritture.
Però DV 12 già dice qualcosa di importante. Sostanzialmente indica due elementi
1. La Bibbia deve essere studiata con criteri scientifici. E DV cita per la prima volta nella storia della Chiesa cattolica quella che all’epoca era considerata quasi un’eresia (!): la teoria dei “generi letterari”. Il problema è che si trattava di una teoria protestante, che era stata creata dallo studioso Hermann Gunkel (1862-1932). Dunque era particolarmente malvista in campo cattolico. Invece DV 12 cita la teoria dei generi letterari esplicitamente, sentenziando che «si deve tener conto fra l’altro anche dei generi letterari». Dunque bisogna studiare la Bibbia da un punto di vista esegetico.
Il documento del 1993 “L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa” sottolinea che l’esegesi storico-critica è una «necessità teologica». Addirittura è una necessità teologica! Papa Giovanni Paolo II scrive che farne a meno significherebbe una mancanza di rispetto verso le Scritture ispirate.
Ciò perché, se la parola di Dio è parola incarnata nella storia e nel linguaggio degli uomini, saltare questa storia significa non capire la Bibbia. Ritenere che si possa leggere la Bibbia prescindendo dalla sua dimensione storica, significa negare l’essenza stessa delle Scritture. Peggio ancora: sostenere che è sufficiente il magistero significa non capire che – come insegna DV 10 – il magistero è al servizio della parola. Esso non è sopra la parola di Dio, bensì ne è al servizio, sebbene molti ritengano che sia sufficiente leggere i documenti del Papa. Dante Alighieri lo aveva capito molto bene, quando nella “Divina Commedia” scriveva:
«Avete il novo e ’l vecchio Testamento,
e ’l pastor de la Chiesa che vi guida;
questo vi basti a vostro salvamento» (Paradiso, V, 76-78).
Chiaramente Dante invita a far riferimento al «pastor de la Chiesa» (il Papa, ovviamente); però prima ricorda «il novo e ’l vecchio Testamento».
2. Tuttavia DV 12 mostra che non è sufficiente neppure lo studio delle Scritture. Pertanto non ci si deve cullare nell’illusione per cui – siccome si è imparato l’ebraico, il greco, il latino, la critica testuale, la storia di Israele, ecc. – si ha capito tutto. DV 12 aggiunge un secondo elemento ermeneutico, spiegando che, per ricercare il senso voluto dallo scrittore sacro, oltre ai mezzi propri dell’esegesi (in particolare di quella storico-critica), è necessario (ed è questa una frase che fu aggiunta in extremis al testo conciliare) che la Scrittura sia «letta e interpretata nello stesso Spirito in cui è stata scritta». Si tratta di un’espressione presa a prestito dall’enciclica “Spiritus Paraclitus” (1920) di papa Benedetto XV, che però è a sua volta debitrice del commento di san Girolamo alla lettera ai Galati. Dunque il documento conciliare pone due criteri uno accanto all’altro: un criterio di ragione e un criterio di fede.
Leggere la Bibbia «nello stesso Spirito in cui è stata scritta» significa concretamente:
1. avere un’idea chiara dell’unità delle Scritture (principio tipicamente patristico);
2. avere un’idea altrettanto chiara della tradizione viva della Chiesa (qui bisogna fare attenzione: non del solo magistero, bensì della tradizione viva della Chiesa, della quale il magistero è parte. Questo è molto importante da capire) ed avere anche un’idea chiara della analogia della fede, ovvero della coerenza e della connessione delle verità di fede tra loro.
Non si tratta di scegliere un criterio a discapito dell’altro, bensì di usarli entrambi insieme.
Dunque la Bibbia deve essere studiata e pregata. Deve essere letta da un punto di vista umano e scientifico e all’interno della tradizione della Chiesa, non l’una senza l’altra. Questo deve fare il fedele che vuole aderire al dettato della DV. L’esegesi è indispensabile, ma lo è anche una lettura di fede.
8. Vera Parola di Dio
in vera parola umana (DV 13)
Tale necessità è fondata da DV 13 attraverso un’azzeccata citazione di san Giovanni Crisostomo, il quale pone un’analogia tra l’incarnazione del Verbo e la Scrittura: come Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, così la Parola di Dio è vera Parola di Dio in vera parola umana. Scrive DV 13: «Le parole di Dio, infatti, espresse con lingue umane, si son fatte simili al parlare degli uomini, come già il Verbo dell’eterno Padre, avendo assunto le debolezze della umana natura, si fece simile all’uomo».
È la teoria di san Giovanni Crisostomo (ca 345-407), che in greco suona “synkatàbasis”, che deriva dal verbo “synkatabàino” (ossia: “scendere giù con”): è la condiscendenza di Dio. Cioè la Bibbia è il segno di un Dio che, come si fa uomo in Cristo, così si fa uomo nel linguaggio, accettando il linguaggio umano con le sue limitazioni. È questo che, ad esempio, pone una differenza radicale – sia detto senza alcun spunto polemico – tra la Bibbia e il Corano. Perché la Bibbia non è il Corano; invece è Parola di Dio incarnata nella parola e nella storia degli uomini e mediata attraverso il linguaggio umano. È per questo che l’esegesi è indispensabile.
Nel suo discorso sull’interpretazione della Bibbia nella Chiesa del 23 aprile 1993, Giovanni Paolo II scrive: «La Chiesa di Cristo prende sul serio il realismo dell’incarnazione ed è per questa ragione che essa attribuisce una grande importanza allo studio storico-critico della Bibbia» (n. 7). E continua: «È questo che rende il compito degli esegeti così complesso, così necessario e così appassionante» (n. 8). Con tre aggettivi il Papa definisce qual è il lavoro degli esegeti: complesso (e nessuno lo mette in dubbio); necessario (questo invece è messo in dubbio da tanti); appassionante (questo lo capisce solamente chi ci si butta e lo fa – appunto – con passione). Complesso, necessario, appassionante: credo che si possa dare pienamente ragione a Giovanni Paolo II.
Dunque l’esegesi biblica è richiesta dalla fede stessa nell’incarnazione; e non ha bisogno di diventare teologica, poiché è già teologica, proprio in quanto storica! Infatti l’esegesi risponde al compito di mostrare il radicamento della parola di Dio nel linguaggio e nella storia degli uomini. L’esegesi fa capire che la Bibbia non è una sorta di “catechismo celeste”, bensì è la Parola di Dio mediata nella storia, attraverso l’esperienza di fede e di vita della comunità ecclesiale, dalla quale la Bibbia nasce e alla quale la Bibbia ritorna.
9. La Scrittura
nella vita della Chiesa (Cap. VI)
Il testo di DV 2 pone così il fondamento dell’intero documento della DV, compresa l’ultima parte del documento, ossia il Capitolo VI, nel quale il Concilio si limita a fare un programma di lavoro, come si evince dal titolo: “La sacra Scrittura nella vita della Chiesa”.
È un programma di lavoro che per lungo tempo è stato chiuso nella Chiesa cattolica. È un programma di lavoro che vuole riportare a quell’“evangelium in Ecclesia” di cui, nonostante tutto, parlavano i padri di Trento.
La DV non ha risolto tutti i problemi relativi all’uso delle Scritture. I documenti successivi (“L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa” e la VD) ne continuano a parlare; e si vede come ancora questo sia un campo su cui lavorare. Però la DV apre una porta: «Parimenti il santo Concilio esorta con forza e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle divine Scritture» (DV 25). Nel 1965 questa era una novità. E continua subito dopo citando la celebre frase di Girolamo: «L’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo».
Il Concilio prosegue poi raccomandando che tutti i fedeli «si accostino volentieri al sacro testo», anche mediante quella che viene chiamata «la pia lettura». È un’espressione interessante, poiché nel 1965 ancora non si sapeva cosa fosse la “lectio divina”. Quest’ultima è un’espressione che è stata rimessa in auge da Enzo Bianchi soltanto negli anni ’70, riprendendola dai padri certosini del Medio Evo. Prima si parlava, appunto, di “pia lettura”; oggi si direbbe: “lectio divina”.
Il Concilio continua: «La lettura della sacra Scrittura dev’essere accompagnata dalla preghiera, affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l’uomo (da notare, di nuovo, la dimensione dialogica); poiché (qui si cita sant’Ambrogio) gli parliamo quando preghiamo e lo ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini». Ritorna nuovamente l’idea di una comunicazione personale di Dio all’uomo.
La DV non rivela molto sul modo concreto di come accedere alla parola di Dio; e il CV II, nonostante le sue aperture, sembra ancora fermo ad un’idea in parte astratta – e forse anche allora illusoria – di un mondo cristiano compatto, nel quale la Bibbia era sicuramente importante. Ma già negli anni ’60 tale idea cominciava sicuramente a vacillare; e a 50 anni di distanza è ancora più evidente.
Però la DV offre tanti elementi: un cammino, un ritorno alle fonti della Scrittura, un’idea larga di tradizione, un concetto non ristretto di magistero, una rivelazione che acquista un sano spessore storico, il fatto che la Bibbia non sia più una fonte di verità da difendere e da proporre come rimedio ad un mondo che, in realtà, ha già rifiutate queste verità.
Come scrive DV 1, la Scrittura diviene un «praeconium salutis», ossia un «annunzio di salvezza», nel quale – come afferma DV 21, con un’altra espressione bellissima – «il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con loro». Questa è proprio un’altra splendida espressione della DV. È un dialogo tra Dio e gli uomini, che fonda il necessario dialogo tra Chiesa e mondo.
I padri conciliari hanno dunque spinto i fedeli a vivere un rinnovamento biblico, che ancora oggi è in fieri e che oggi molti attuano. Qui si aprirebbe un capitolo pratico, ossia come e con quali attività diffondere e far amare la Bibbia. Bisognerebbe verificare se si sia messo in pratica quello che scrive Benedetto XVI, quando si chiede se la Bibbia occupi davvero il posto centrale della nostra attività pastorale (VD 73). E ammonisce che non si tratta di giustapporre la Bibbia ad altre forme di pastorale (facendo magari qualche incontro biblico in più), bensì di animare biblicamente l’intera pastorale. Dunque tutto ciò che si fa dovrebbe essere biblico. Bisogna chiedersi se ciò è veramente entrato nel popolo cristiano oppure deve ancora entrare.
Per il rapporto tra esegesi e fede, rimando al mio articolo che si trova nel volume approntato per festeggiare i 25 anni del C.I.B.: “Lampada per i miei passi è la tua parola – 25 anni di C.I.B.”.
10. Auguri
Concludo facendo gli auguri al C.I.B. nel suo 25° anniversario.
Permettetemi di fare l’augurio in maniera più solenne come Presidente dell’A.B.I. – Associazione Biblica Italiana. Questo vuol essere un segno di stima da parte dell’A.B.I. È un augurio ufficiale e solenne che l’Associazione Biblica Italiana rivolge al Centro d’Informazione Biblica di Carpi.
Gli auguri sono tre.
1. Traggo il primo augurio dall’inizio e dalla conclusione della VD. Per due volte, il papa Benedetto XVI scrive che l’annunzio della parola crea comunione e realizza la gioia (n. 2 e n. 123). Ed è proprio sulla gioia che si apre e che si chiude il documento.
Allora l’augurio è che tanti anni di studio della Parola di Dio abbiano creato in voi una vera comunione (infatti la Parola di Dio non è per i singoli, ma è per una comunità credente; non è consegnata per un singolo individuo, bensì per creare comunione) e che abbiano fatto nascere in voi la gioia di questo incontro con un Dio che, nella sua Parola, Si rivela agli uomini.
2. Traggo il secondo augurio dai Padri della Chiesa. Papa Gregorio Magno (540 ca-604) scrive a Teodoro, medico dell’imperatore questo celebre testo: «Cerca dunque, ti prego, di meditare ogni giorno le parole del tuo Creatore. Impara il cuore di Dio nelle parole di Dio» («Disce cor Dei in verbis Dei»). Nell’espressione di Gregorio Magno la parola è, per il credente, un incontro personale con Dio stesso.
Nel suo monumentale commento a Giobbe, Gregorio Magno scrive ancora: «Nei confronti di tutta la scienza e di tutto il sapere umano la sacra Scrittura è talmente elevata che io non posso tacere. Essa viene in aiuto dell’animo del lettore con parole semplici e lo eleva ai sensi più sublimi. In un certo senso la Scrittura cresce con chi la legge. Anche i lettori più inesperti possono capirla e, tuttavia, i dotti la troveranno sempre nuova». È un’altra espressione famosa: «Scriptura crescit cum legente». Questo principio di papa Gregorio ricorda che la vita, l’esperienza, lo studio, che ogni credente fa delle Scritture, fa crescere sempre più la comprensione delle Scritture stesse.
E – aggiungo io – rende la Chiesa sempre più calata nella storia umana, nella quale la parola si è fatta carne in Cristo, una storia che la Parola di Dio, contenuta nelle Scritture, insegna ogni giorno a comprendere e ad amare.
3. Traggo il terzo ed ultimo augurio dalla DV, che ricorda che «nella parola di Dio è insita tanta efficacia e potenza» (DV 21). Si potrebbe dire: una carica esplosiva, che troppo spesso i cristiani e le chiese hanno cercato di disinnescare, rendendola il più possibile innocua. Ma auguro che, grazie anche al C.I.B., questa efficacia e potenza della parola di Dio esploda con tutta la sua forza, secondo quello che scrive il profeta Geremia: «La mia parola [la parola di Dio] è come un fuoco, è un martello che spezza la roccia» (cf. Ger 23,29). La spezza non per distruggere, la brucia non per consumare, ma per scaldare, per illuminare e per costruire.